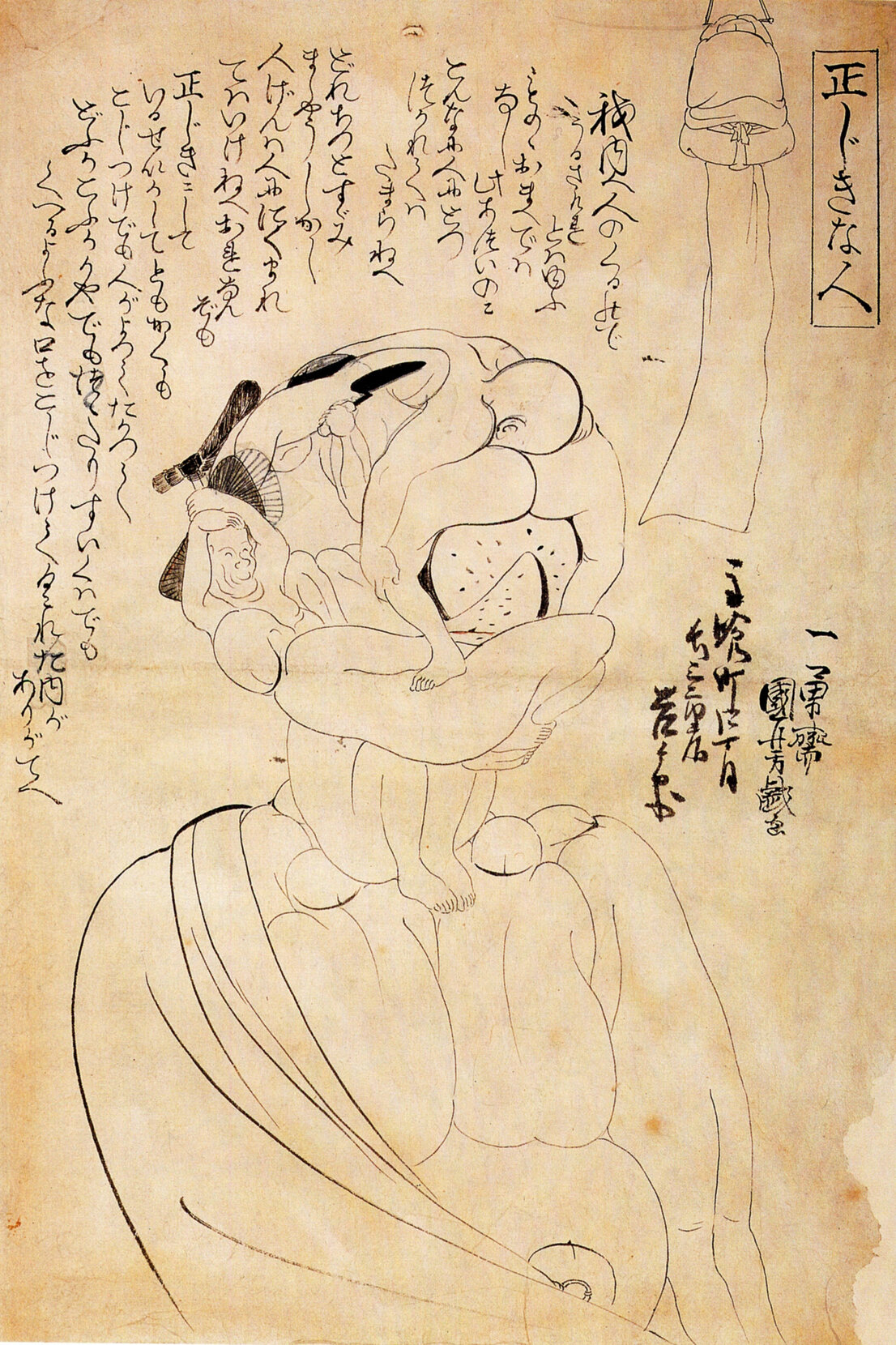PROGETTI
Per chi si muove, gli orizzonti si spostano
Citando Michela Murgia (2024), racconto qui di movimenti e orizzonti. Relativamente allo studio e alla ricerca – sulla base di un orizzonte di senso e di una postura critica fenomenologico-gestaltica – mi interesso soprattutto:
- di storia della psicologia, storia della psichiatria e storia della medicina: non possiamo comprendere la direzione della contemporanea professione psicologica (con riferimento specifico alla dimensione clinica) e la sua funzione all’interno dell’attuale contesto storico, politico, sociale, culturale senza conoscerne le radici e quali de-cisioni nel tempo ne hanno caratterizzato la crescita fino alla situazione attuale. Per conoscere la psicologia serve anche, necessariamente, conoscere la professione medico-psichiatrica.
- della controversa relazione tra queste scienze cliniche del mentale e del complesso rapporto tra i rispettivi professionisti: storicamente, psicologia (clinica) e psichiatria si sono raramente incontrate lasciando predominare precomprensioni, incomprensioni, scontri, assenze fino ad arrivare all’attuale anestesia rispetto all’impatto di tutto questo nella co-costruzione di percorsi terapeutici realmente incentrati sulla persona nella sua interezza. Potete recuperare per un’introduzione il mio intervento al seminario Sentieri sulla salute mentale: “Ossessione identitaria e convivenza interprofessionale”.
- della radicata crisi in cui si trovano tanto la psicologia quanto la psichiatria contemporanee: una crisi della presenza, del predominare di un’anestesia alle con-nessioni; una crisi della sanità pubblica come della sanità privata e dello stato di salute della salute mentale italiana. In queste riflessioni sono essenziali autori quali Alessandro Salvini, Benedetto Saraceno, Gilberto Di Petta, Piero Cipriano, Paolo Francesco Peloso. A proposito ho scritto: “Sul senso della clinica in medicina”, “Sul senso della clinica in psicologia” e “Sulla clinica, sul letto e sull’inclinarsi”.
- di formazione universitaria: il professionista era studente. L’ossessione identitaria e la controversa relazione tra psicologia (clinica) e psichiatria si presentano prepotentemente sin dalla formazione universitaria, perpetuando incomprensioni, scontri, assenze: una formazione morta, incapace di potenza poietica. A proposito ho scritto: “Concezione identitaria, forma mentis e formazione universitaria nelle scienze cliniche del mentale. Quale spazio si lascia al saper-essere?” e “Dalla formazione al saper-essere nelle scienze cliniche del mentale”.
- dei costrutti di identità, individuo, individualismo: non siamo mai identici, siamo simili e contemporaneamente differenti, un intrico di somiglianze e differenze; non siamo nemmeno individui: siamo con-dividui, con-figurazioni in costante trasformazione, un raccordo di forme radicate in un terreno di connessioni, luoghi di com-partecipazione; non possiamo vivere in una contesto societario individualistico: ci serve riscoprire la potenza del con- e di una comunità con-dividuale. Essenziale riferimento sono i testi dell’antropologo Francesco Remotti. Potete a proposito recuperare l’articolo “Per una postura dell’incanto, un terapeuta-cittadino e una società con-dividuale”, scritto per il nr. 0 della rivista Adombramenti.
- di psicologia e psichiatria critica (prospettiva filo-basagliana): una postura critica deve portare necessariamente a una contaminazione poietica finalizzata a realizzare concretamente qualcosa di bello. Lo studio antropologico delle forme di convivenza, di comunità impossibili, di prendersi cura esistite e esistenti permette di creare nella propria professione e nella propria vita contesti comunitari di compartecipazione vissuta per restituire respiro, libertà, vita. “Non è importante tanto il fatto che in futuro ci siano o meno manicomi e cliniche chiuse. È importante che noi, adesso, abbiamo provato che si può fare diversamente: ora sappiamo che c’è un altro modo di affrontare la questione, anche senza la costrizione” (Franco Basaglia, 1979). Anche qui rimando all’articolo “Per una postura dell’incanto, un terapeuta-cittadino e una società con-dividuale”, scritto per il nr. 0 della rivista Adombramenti. Ne parlo anche durante un intervento per Robe da Matt*.
ARTICOLI
CONVIVENZA
Durante questi anni mi sono dedicato con cura allo studio della relazione tra le professioni psicologica e psichiatrica. Ci sono state persone a me care che sono state infilate, gettate in percorsi di cura non-curanti della persona stessa, frammentati: in alcuni casi un’insensata, anestetizzante terapia psicofarmacologica in assenza di alcun supporto psicologico/psicoterapeutico – essenzialmente uno psichiatra incapace di comunicare con il proprio paziente oltre la prescrizione di farmaci; in altri l’esatto opposto, ossia insistere in un percorso psicologico senza rendersi conto della necessità di un supporto medico/psichiatrico. E questo per diversi anni, non per un breve e anche comprensibile periodo di inquadramento del disturbo. Le situazioni si sono risolte cambiando professionista, fino a trovarne qualcuno disposto a complessificare il percorso di cura, a riconoscere la limitatezza delle proprie conoscenze/competenze, e a inclinarsi – come dovrebbe ricordare proprio il termine clinica – all’incontro interprofessionale.
Mi interessa parlare della relazione tra psichiatria e psicologia come di un qualcosa che ancora incide, in maniera significativa, sulla crisi in cui si ritrovano queste scienze cliniche; quella crisi che le vede assenti alla cura stessa, assenti alla persona, a stare nell’incontro con l’altro, a essere presenti. Proprio questa crisi credo sia derivata – o almeno acutizzata – dalla non accettazione da parte di queste professioni del proprio poter-essere altro da quello che si sono dovute imporre di essere per esistere (ec-sistere, inteso qui come un emergere, un sopravvivere) e per coesistere all’interno del contesto storico-culturale e scientifico presente a partire dalla fine del 1800.
Un contesto – di cui alcuni aspetti ritroviamo tutt’ora – in cui per conoscere si doveva necessariamente spaccare subatomicamente ciascun sapere – senza premurarsi di ricomporlo – e creare iper-specialismi tanto specializzati, identitariamente definiti quanto incomunicanti, soli nel proprio confinato sapere. Le polifeniche scienze cliniche del mentale sono risultato di questo pensiero frammentante: sono nate da una spaccatura originaria dell’uomo e – spaccate tanto quanto l’uomo – si sono dovute adattare per sopravvivere. Da qui la ricerca – divenuta ossessiva nel tempo – di un proprio definito spazio identitario capace di legittimarne l’esistenza e contemporaneamente permetterne la coesistenza: questo le ha chiuse all’incontro, alla convivenza, portando a risposte di isolazionismo e protezionismo professionale (CNOP, 2008), e ha contemporaneamente accentuato quella stessa originaria lacerazione dell’essere umano e della sua sofferenza non permettendo di tendersi oltre – se non in questi ultimi anni – per compiere un’operazione di ritessitura dell’uomo e della cura. Parlare della relazione tra queste scienze cliniche significa quindi contemporaneamente parlare di chi siano o – provocatoriamente – chi credano di essere.
Racconto tutto questo in quanto sto lavorando a un corso di formazione specificatamente dedicato a come storicamente sia maturata la relazione tra psicologia (clinica) e psichiatria e tra psicologi (clinici) e psichiatri. Se siete interessati – da professionisti o da cittadini – a aiutarmi in questa ricerca, potete dedicare qualche minuto alla compilazione di un breve questionario. Trovate tutto qui sotto.